Mi sono inventata un gioco su Instagram: voi mi mandate tre parole, io creo dei racconti personalizzati per tenervi compagnia durante la quarantena. Ecco il terzo, per Mario.
Enrico fumava lentamente, godendosi il catrame dalla prima nota all’ultima. Guardava la città dal minuscolo balcone di un QuintoPianoSenzaAscensoreMaConVistaSpettacolare, come era stato definito dall’agente immobiliare quel buco. In sottofondo Hiromi Uehara riempiva il bilocale con il suo jazz che voleva essere allegro ma che inevitabilmente falliva nel suo intento e sembrava un po’ triste, filtrato male dai sentimenti malinconici di chi lo ascoltava. Le auto dall’altro lato della strada scorrevano di sotto con la flemma delle sei di una sera di agosto: il resto della città era vuoto ma non il quartiere che stava guardando Enrico, il quartiere di chi non si ferma per le ferie. Le tende colorate dei banchi del mercato da questo lato della strada, invece, strappavano la folla dal tempo, relegandola allo spazio che dalla Chiesa forse più povera del mondo raggiungeva l’ufficio postale forse più affollato del mondo. I bambini correvano come se fossero in un campo di calcio, evitando le persone e senza mandare fra le auto l’unica palla a disposizione: Enrico pensava a quando lui e José si passavano una Super Santos sgonfia nella piazza di un’altra città e di un’altra era ma con la stessa convinzione dei Pelé che stava guardando. José aveva continuato a giocare anche quando Enrico aveva scelto di iscriversi al liceo, anche quando si era diplomato e aveva deciso di proseguire con gli studi. José era un vero talento: la zazzera di capelli neri al vento e le gambe corte ma muscolose sempre attive, era una punta nata. Il sorriso smaliziato e le volgarità che uscivano da quella bocca rendevano José il più desiderato dalle ragazze, che morivano di fame dietro ai suoi no perché quel testone non si levava dalla testa Maria della terza A, i capelli rossi e ricci da far invidia alle più belle modelle di questo mondo e dell’altro. Mentre José veniva arruolato in serie c, Enrico studiava psicologia, chiudeva gli occhi nel suo letto che aveva solo rete e materasso e si vedeva in una casa con tanto di salone, con le tende bianche e un giradischi. Il giradischi e le tende bianche li aveva: gli mancavano il salone e José, che si sentiva di aver ucciso dopo una serata in discoteca. Le statistiche dicono che negli incidenti mortali a perdere la vita è quello sul sedile del passeggero e quando nella loro seicento erano stati travolti da un pazzo che correva incurante del rosso, José ci aveva lasciato penne, talento e sogni.
Enrico pensava continuamente che avrebbe potuto frenare prima, che avrebbe potuto tenere spenta la radio, che avrebbe potuto far guidare José e morire al posto suo. Sapeva di non poter vivere di rimorsi e di non avere responsabilità ma cercava una qualche forma di redenzione e riconosceva di avere un senso di colpa perenne e doloroso che lo portava a punirsi con piccole privazioni stupide come la casa molto più minuscola e lurida di quanto avrebbero consentito le sue possibilità, le sigarette economiche e sature di catrame che si fumava come un turco, i fuochi a induzione che aveva comprato quando aveva letto che potevano essere cancerogeni. Il compito di Enrico era quello di aiutare gli altri ad uccidere i propri mostri ma non aveva la minima intenzione di affrontare i suoi e galleggiava nella vita come un pesce rosso in una boccia, con la differenza che i pesci sono ignari di tutta l’acqua che si perdono mentre Enrico non lo era e si torturava senza posa per ogni errore, dal più insignificante a quello che considerava il peggiore della sua vita. I sogni ricorrenti lo tormentavano come nei più classici casi di trauma, neanche a dirlo. L’unica valvola di sfogo che aveva trovato per placare suo dramma interiore era proprio quel jazz ripetitivo e malinconico come i suoi pensieri e così, memore delle lezioni di piano che gli aveva dato quel fannullone di suo padre come unica eredità, aveva acquistato una pianola per improvvisare con gli amici del bar con le luci blu.
Pensava tutto ciò mentre guardava la città alle sei di una sera d’agosto qualsiasi, senza immaginare che proprio in quel bar dalle luci blu avrebbe incontrato lei, la più bella forma d’arte che si fosse mai vista, che avrebbe fumato con lui sul balcone del QuintoPianoSenzaAscensoreMaConVistaSpettacolare e gli avrebbe tolto dalla testa, solo ogni tanto, qualcuno dei suoi errori.
Questo racconto è dedicato a Mario,
Carlotta Di Cretico.

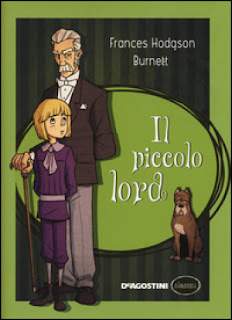
Commenti
Posta un commento